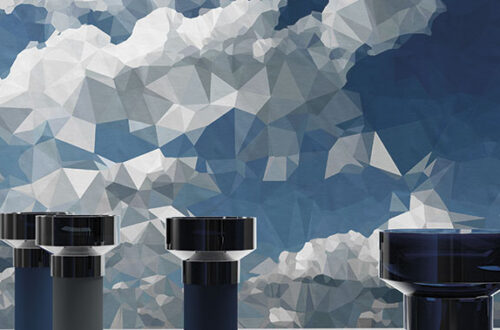Le case che (forse) costruiremo
Parte seconda
Abbiamo ripreso con piacere la lettura di Luca Molinari (Le case che siamo, Nottetempo Editore): pagine succulente le sue, per scrittura e contenuti. Ci aiutano a ragionare, a ritornare sul tema dell’abitare e delle sue molteplici sfaccettature.
Tuttavia certe obiezioni, al suo
pensiero, vanno lealmente mosse.
In più parti del libro, per esempio, l’Autore ci invita a “guardare a questi decenni che ci hanno intossicato con milioni di metri cubi di cemento e con case che facciamo fatica ad abitare … un laboratorio globale da manipolare con cura e da cui trarre lezioni utili” (p.59).
Tutto vero, condivisibile, non possiamo che arrenderci di fronte alla suggestione di queste asserzioni, oggi soprattutto che va di moda essere green.
Condivisibile la genuina aspirazione che in un futuro molto prossimo si possa edificare con le migliori intenzioni, tuttavia i decenni trascorsi hanno richiesto tutti quei metri cubi che lui lamenta.
Quell’edilizia abbraccia in qualche modo la storia dell’Italia operaia e contadina, figlia del nostro boom economico. Occorre considerare l’epoca, le necessità e, non ultime per quel periodo, le normative. Un esempio può aiutare e, se non conforta le idee dell’Autore, offre quanto meno una possibile chiave di lettura.

Le Compagnie di Assicurazione, per obbligo di legge, dovevano impiegare una quota dei loro premi in immobili: la più parte rientrava nel comparto residenziale.
La conseguente necessità di razionalizzarne la gestione e manutenzione ha probabilmente prediletto non già la creatività degli architetti, la pianificazione (zoning) o la loro determinazione a proporre nuovi modelli abitativi, bensì una “manica architettonica” e una funzionalità, anche manutentiva, che ne ha condizionato gli esiti edilizi.
Troviamo perciò nelle periferie, unici spazi dove costruire abitazioni per una popolazione in crescita e in pieno inurbamento, edifici simili (se non uguali) e appartamenti spesso replicati identici su tutti i piani. La conseguente semplificazione impiantistica (coltivata con cognizione ancora oggi seppur con più moderazione) riduceva i costi di realizzazione e rendeva razionali le procedure di gestione.
Fa bene Molinari a lamentarsi di quelle tipologie di costruzioni e della sconcertante mancanza di pensiero urbanistico. Era così. E’ come se guardassimo, con gli occhi dell’oggi, una locomotiva a vapore.

Un’edilizia di quel tipo, imperante dagli anni Sessanta fino al termine degli Ottanta, ha colonizzato così durevolmente il territorio urbano da determinarne il paesaggio che oggi vediamo. Ma è anche quella che ha permesso all’Italia della fatica e del lavoro di sperare in qualcosa che potevamo identificare come “il nostro futuro”. Per esempio un’abitazione dotata di cucina (con acqua corrente e bombola del gas) o scaldavivande, del salotto (che oggi preferiamo chiamare living) e finalmente di un bagno (privato).
Ci sentiamo però di aggiungere un paio di note. Non tutte le periferie sono uguali, persino all’interno della stessa città, e per nostra fortuna nessuna raggiunge i tristi connotati delle banlieues francesi. Esistono aree dove, attualmente, l’emancipazione non è ancora avvenuta, il contagio con spazi centrali e più decorosi della città non ha prodotto i benefici sperati ma ha invece sedimentato un malessere che spesso s’è trasformato in isolamento, degrado, malavita.
Altre periferie, al contrario, rimangono ancor oggi più che vivibili. Nell’uno e nell’altro caso sappiamo dire se sia “colpa” dell’architettura, dell’urbanistica o dei milioni di metri cubi rovesciati sul territorio?
O se esista qualche altra motivazione?
Ha ragione l’Autore nel definire la periferia un laboratorio globale da cui trarre lezioni utili. Ci servirebbero degli esempi che, però, non possono essere solo “stranieri” (Lacaton & Vassal a Bordeaux; NL Architects ad Amsterdam; MIT di Cambridge in Massachussetts – p.117).
L’Autore dovrebbe aiutarci in questo.


I riferimenti (anche bibliografici) a esperienze costruttive estere può costituire indubitabilmente un’informazione, una riflessione, una speculazione “filosofica” sulla composizione architettonica, tuttavia ogni Paese ha proprie discipline, normative, tempistiche, ecc. che andrebbero coniugate con il territorio, i mezzi, la volontà (anche politica), ecc. tipiche dell’Italia. Come pure con i modelli abitativi, la consuetudine degli spazi e edifici pubblici, la plasticità culturale, ecc. E poi considerare che, contrariamente alle nostrane proprietà immobiliari frazionate fra condòmini, là la maggioranza dell’edificato appartiene a organismi pubblici o a Fondi immobiliari o pensionistici che possono, in quanto detentori di interi edifici o aree, intervenire con un’attenzione diversa in relazione alle mutate esigenze sociali.
C’è dell’altro. Questi recentissimi anni, con l’avvento dei viaggi, dell’infotainment e, in generale, del web, hanno cambiato, a nostro parere, il modo di approcciare le cose e di abitare le case: urbanistica e architettura stanno reagendo nel migliore dei modi. Non è un caso se si parla di rigenerazione urbana, di “rammendo” di certe aree abitate, di recupero e trasformazione di edifici esausti e spazi pubblici.
Se saremo bravi, in questo futuro che sta veramente dietro l’angolo, a mitigare lo iato centro/periferia è anche per questa possibilità di riprogettazione: è già in atto una progressiva visione policentrica della città rispetto ad una divisione ormai consunta di interno/esterno. Il quartiere con le sue infrastrutture e la sua riconquistata identità assume nuovi connotati favorendo una qualità dell’abitare che fino a pochi anni fa era solo aspirazionale.

In ogni caso, come accennavamo all’inizio, un paio di obiezioni al testo vanno lealmente mosse.
Questa, per esempio: “… mi concentrerei sulle soglie: le soglie separano ambiguamente i confini, sempre più smagliati dalla metamorfosi che il nostro mondo sta vivendo … domani diventeranno l’occasione per stabilire una “distanza sociale di sicurezza” o, invece, uno spazio per costruire nuovi contratti sociali per il futuro” (p. 123-124).
E’ intellettualmente interessante ma, da un testo che ci parla di case e architettura, si rischia che il tutto rimanga un po’ aleatorio. Ci avrebbe intrigato qualche idea in più: scritta così sembra aderire ad un dettato politicamente corretto ma che non ci permette di tastare tutta la concretezza di cui, da sempre, si nutre l’architettura.
Un altro esempio: “Perché non lavorare sullo spessore delle nostre finestre affinché diventino spazi da abitare, confessionali aperti sul mondo …?” (p.125). Verrebbe da obiettare che se il problema davvero fosse quello di recuperare l’imbotte delle finestre (ma soprattutto delle portefinestre, secondo noi) è probabile che possa bastare un’impresa edile. Ma, oltretutto, di quanta superficie stiamo parlando? Diciamo 20/30 centimetri di profondità? E ciò risolverebbe lo spazio da abitare?
Identica perplessità emerge qualche riga dopo: “Perché non immaginare piccoli, diffusi bagni collettivi in cui il tema dell’igiene e della sicurezza diventino anche occasioni di cura del corpo e incontro con i sensi?” (p.126).
Avevamo i calzoni corti quando i bagni erano fuori casa, sui ballatoi comuni o nei cortili e non ricordiamo di recenti rimpianti rispetto all’intimità offerta dai servizi igienici, privati, all’interno delle nostre case. Proporre questo genere di interventi di architettura rischia di non andare al di là del sorriso e, forse, della nostalgia.
Occorre, come dice giustamente l’Autore in altre pagine a nostro avviso più riuscite, ripensare l’architettura come un laboratorio di sperimentazione per nuovi canoni edilizi e con una nuova mentalità.
Vogliamo fare nostro il cristallino invito attribuito ad Einstein, secondo il quale: “Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo”.
s f o g l i a l a g a l l e r i a