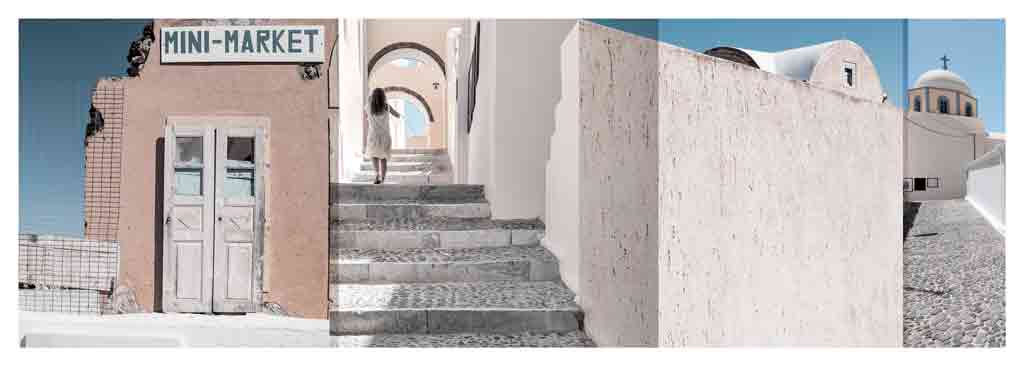Ilenio Celoria: la fotografia di ricerca.
La diffusione di una cultura collettiva dell’immagine come “obiettivo” primario.
 È del 16 maggio 2022 la prima email:
È del 16 maggio 2022 la prima email:
“Buonasera Ilenio, sono Annamaria Cassani, architetto e responsabile del magazine digitale www.folderonline.it. Ho visitato proprio ieri le mostre fotografiche a Casale Monferrato in occasione dell’evento MonFest 2022. Sono rimasta particolarmente colpita dal suo lavoro sugli Infernot che ho trovato molto “architettonico” e, solo dopo, leggendo la sua biografia, ho capito perché. Vorrei proporle un’intervista per un articolo sulla nostra rivista che la invito ad esplorare. Mi piacerebbe poter parlare dei suoi lavori. La ringrazio, Anna”.
Il 19 maggio 2022 riceviamo la email di risposta:
“Gentilissima Annamaria, sono molto contento che il mio lavoro le sia piaciuto. Le fotografie sono il risultato di un lungo percorso di ricerca sulla percezione e sulla rappresentazione dello spazio architettonico. Ho visto il vostro magazine […]. Mi farebbe molto piacere approfondire il mio lavoro in un’intervista. Attendo una sua chiamata per concordare un incontro. Poiché sono un docente potrei non rispondere in alcuni momenti, nel caso le chiederei cortesemente di inviarmi un messaggio con un orario preferito per poterla richiamare. La ringrazio. Cordiali saluti. Ilenio Celoria”.
È tramite una videochiamata che cominciamo a parlare e, con una naturalezza inaspettata, vien subito di darsi del tu.


Annamaria Cassani
Ilenio, come definiresti il tuo tipo di fotografia?
Ilenio Celoria
La mia è una fotografia di ricerca e sperimentazione. Per natura sono molto curioso e da sempre guardo con lo stesso interesse sia la produzione fotografica che quella di architettura e d’arte contemporanea. Arte e architettura sono i miei poli d’attrazione, gli ambiti nei quali faccio confluire le mie personali sperimentazioni che successivamente condivido con i miei studenti.
Mi piace paragonare la mia professione di insegnante a quella dei maestri di bottega rinascimentali che guidavano gli apprendisti nella realizzazione dei lavori che, di fatto, risultavano percorsi di ricerca collettiva.
A.C.
Prima di addentrarci negli argomenti specifici ci spieghi cosa sono gli “infernot” di cui ho appreso l’esistenza solo qualche settimana fa visitando la tua esposizione?
I.C.
Gli infernot sono degli spazi sotterranei, di piccole dimensioni, collegati alle cantine delle abitazioni e scavate nell’arenaria (Pietra da Cantoni) direttamente dagli stessi proprietari della casa sovrastante, allo scopo di conservare il vino imbottigliato. Questi piccoli locali non sono dotati di luce né di aerazione naturale. Ci sono diverse tipologie di infernot ma tutte sono accomunate da un’atmosfera decisamente suggestiva, quasi sacrale se li si pensa illuminati dalle luci delle candele.


A.C.
Nel corso del nostro primo contatto accennavi alla necessità di una visione più contemporanea di rappresentazione delle architetture attraverso la tecnica fotografica. Mi spieghi?
I.C.
La fotografia di architettura sin dalla nascita è stata legata ad una visione prospettica di tipo rinascimentale e mi riferisco ai lavori dei Fratelli Alinari che hanno fatto scuola nell’Italia del XIX secolo: l’obiettivo era quello di restituire un’immagine che si avvicinasse il più possibile a quella che avrebbe percepito l’occhio umano, una rappresentazione prospettica molto simile a quella sulla quale noi architetti ci siamo formati.
La fotografia contemporanea d’architettura grazie alle nuove, avanzate strumentazioni che la tecnologia mette a disposizione -impensabili un tempo- si orienta verso una rappresentazione solo “apparentemente” oggettiva. L’impiego sempre più frequente di ottiche grandangolari, caratterizzate da un ampio angolo di campo, genera un’alterazione percettiva dei rapporti spaziali. Il risultato? Il nostro punto di vista si allarga con la possibilità di veder rappresentate sullo stesso piano cose che nella realtà noi potremmo percepire solo con la coda dell’occhio.
Un altro aspetto introdotto dalla fotografia contemporanea, e qui voglio fare riferimento ad esempio alle opere realizzate in bianco e nero da Gabriele Croppi, è il forte contrasto tra luce ed ombra.
Per quanto riguarda la mia fotografia
io sento la necessità di andare oltre la mera rappresentazione architettonica per esplorare il “territorio dello sguardo” ed offrire inaspettate percezioni.
Nel lavoro fatto sugli infernot, ad esempio, ho voluto restituire con i miei scatti due tipi di percezioni. L’atmosfera permeata di “sacralità” a cui ho già accennato e che ho vissuto mentre mi trovavo in questi luoghi. Spesso infatti erano illuminati dalla sola luce delle candele: ho ritenuto che le sensazioni che mi hanno coinvolto in quei momenti dovessero essere riproposte attraverso l’utilizzo di un normale grandangolare, e così ho fatto. L’altra sensazione riferiva una dimensione dello spazio che ho ottenuto attraverso l’utilizzo di una particolare fotocamera che restituisce un’immagine a 360°. Mi piace riflettere su questo tipo di immagini che offrono uno spazio di dialogo tra architettura ed arte.



A.C.
Hai già quindi introdotto il tuo lavoro “PHOTOMORPHOSIS (INFERNOT) che hai esposto nel corso della prima edizione “MonFest 2022 – LE FORME DEL TEMPO” che si è svolta nella città in cui sei nato e lavori, Casale Monferrato. Sono in errore se penso di essermi trovata dentro ad una visione “escheriana” degli ambienti che tu hai fotografato?
I.C.
Prima di rispondere alla tua domanda devo fare una breve premessa: il mio lavoro sugli infernot inizia nel 2001 su invito del collega professor Paolo Ceresa: si trattava di un lavoro didattico, un censimento di questi manufatti ipogei da sempre presenti nel nostro territorio ma mai realmente valorizzati, che prevedeva la collaborazione tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leardi” di Casale Monferrato, uno degli istituti in cui insegno, e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni.
Il risultato di questo primo approccio agli infernot è entrato a far parte della documentazione posta sul tavolo dell’UNESCO che, nel 2014, ha dichiarato i “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato”, all’interno dei quali troviamo “Il Monferrato degli infernot”, patrimonio dell’umanità.
Terminata questa prima fase di tipo documentativo ho sentito l’esigenza di non abbandonare il racconto su questi manufatti ma di proseguirne la lettura con uno sguardo diverso: volevo restituire la sensazione di sorpresa che si prova nell’arrivare in questi spazi ipogei -sorta di architetture “in negativo” ottenute sottraendo materiale generalmente collegati alle cantine delle abitazioni attraverso strette aperture o cunicoli.
Ho pensato ad una tecnica differente, un’ottica fuori dagli obiettivi standard -che in ogni caso non sarebbero stati adatti alla restituzione di spazi così ristretti- ed ho perciò impiegato una fotocamera che produce immagini sferiche attraverso due obbiettivi fisheye che mi ha consentito di scattare fotografie a 360°.
Ritornando alla tua domanda, sono le rappresentazioni stereografiche tratte da questi scatti che hanno contribuito a trasmettere l’atmosfera che hai definito “escheriana”: una percezione insolita dovuta ad una consapevole forzatura della rappresentazione di questi spazi dalle caratteristiche uniche.
A proposito dell’unicità voglio citare Mario Giacomelli che paragonava i solchi dei campi arati che ritraeva nei suoi scatti a quelli presenti sulle mani dei contadini che li avevano tracciati: analogamente mi piace pensare di ritrovare sulle pareti di pietra scavate direttamente dai proprietari degli infernot i segni distintivi del lavoro e la fatica delle loro mani.




A.C.
Proseguiamo sugli infernot. Il tuo lavoro esposto nella splendida cornice del castello di Casale Monferrato ci ha colpito sin dai primi scatti: ci è sembrato che location e fotografie si siano reciprocamente valorizzate. Quanto è importante, secondo te, l’ambiente in cui le opere vengono esposte? Il tuo lavoro sugli INFERNOT sarebbe “arrivato” con egual forza se esposto in un ambiente meno ricco di suggestioni?
I.C.
Sicuramente no e spiego subito il perché. Tutte le componenti del progetto sono state studiate in funzione del sito dell’esposizione. Il torrione del Castello era il luogo ideale per far respirare un’atmosfera che fosse più vicina possibile a quella che si ritrova negli infernot. Per trovare le giuste corrispondenze tra foto e luogo fisico l’intero itinerario è stato organizzato puntualmente: dalla sequenza delle immagini alla tipologia e intensità dell’illuminazione, fino alla proiezione a soffitto del filmato che si vede a fine percorso, in cui l’unico suono che si percepisce ad intermittenza è quello del gocciolio dell’acqua.
A.C.
All’interno del medesimo evento citato nelle domande precedenti era presente il lavoro “Gabriele Basilico nel Monferrato”, una selezione delle foto scattate nel 2006 tra Casale, Alessandria, Ovada e Tortona. Anche Basilico era architetto e il suo lavoro di tipo documentario veniva restituito con un’impronta quasi metafisica; fondamentale importanza era la scelta del punto di vista di cui “andava alla ricerca alla stregua di un rabdomante”. Cosa pensi della sua opera?
I.C.
Ho avuto il piacere di conoscere Gabriele Basilico alla facoltà di architettura di Genova dove mi sono laureato e dove sono attualmente docente a contratto. Ad uno sguardo distratto il suo tipo di fotografia può apparire più simile a quella del periodo che l’ha preceduto ma lui utilizzava focali più ampie ed un punto di vista ad altezza uomo che lo affrancano da uno stile che mirava ad una restituzione più astratta delle architetture.
La fotografia di Basilico è chiaramente di tipo documentario ma con l’intento di aver spostato lo sguardo sui comuni e quotidiani luoghi della trasformazione urbana realizzandone veri e propri ritratti, cui ha conferito una “dignità” paragonabile a quelli realizzati per luoghi più consolidati delle città
Da sempre ritengo, e l’ho sperimentato proprio su di me, che chi ha conoscenze di composizione architettonica riesce a possedere quel senso dello spazio che gli consentirà, ogni volta, di scegliere il punto di vista migliore per quello che io penso debba essere lo scopo di questo genere di fotografia: la “contemplazione” dell’opera architettonica.
È di fondamentale importanza sapersi collocare esattamente nel punto che permette di valorizzare e restituire al meglio le geometrie e i rapporti tra pieni e vuoti. Altrettanto imprescindibile è la scelta della luce che può essere più o meno diffusa a seconda del traguardo che si vuole raggiungere, più equilibrato piuttosto che maggiormente contrastato.
A.C.
Fotografi come Antonio Biasiucci, Gianni Berengo Gardin, Sebastiao Salgado, solo per citarne alcuni, sono considerati dei maestri contemporanei della fotografia in bianco e nero. Qual è la tua opinione rispetto all’utilizzo di questa tecnica? Può essere ancora oggi considerabile di tipo documentario oppure diventa esclusivamente di tipo espressivo/artistico?
I.C.
Non si possono fare considerazioni generali sul bianco e nero se non, forse, quella di sottolineare come, eliminando dall’immagine i colori, si abbia come risultato quello di convogliare maggiormente l’attenzione sulle forme.
Di fatto non esiste un unico modo di “fare il bianco e nero”.
L’utilizzo di dispositivi digitali e l’attività di post-produzione hanno spostato l’attenzione sul “profilo colore” come strumento per rafforzare gli aspetti legati all’emotività, tant’è che possiamo parlare di “tonalità emotive” anche in ambito fotografico.
Come per il colore, anche per il bianco e nero vale la stessa cosa: la post-produzione deve, anche in questa circostanza, essere eseguita con cognizione di causa perché la qualità espressiva di questa tecnica dipende dall’ampiezza della gamma tonale che si decide di adoperare.
Un’ampia gamma tonale, come quella utilizzata da Berengo Gardin, rafforza il valore documentario dell’immagine fotografica. Nel caso specifico di Berengo Gardin, che ho avuto occasione di incontrare più volte, il suo “integralismo” nel proporre il bianco e nero è legata, a mio avviso, al periodo in cui si è formato, un momento storico in cui la fotografia a colori ancora non soddisfaceva le esigenze estetiche dei fotografi che avevano come punto di riferimento i grandi Maestri della fotografia. Voglio ricordare che i suoi maestri sono stati Willy Ronis e Robert Doisneau, due fotografi francesi tra i più grandi del secondo dopoguerra, che condividevano il comune interesse di riprendere la vita di strada riconoscendo nelle loro immagini la “bellezza dell’ordinario”.
Salgado utilizza immagini molto contrastate per sottolineare l’importanza dei soggetti che ritrae, pervasi da un senso di drammaticità: mi riferisco soprattutto al lavoro “Workers” in cui quello che viene messo in scena è la condizione dell’uomo che lavora e che affronta la continua lotta contro le difficoltà della vita.
Anche nei “Riti” di Biasiucci il dramma emerge dal nero profondo delle immagini che ritrae.
Un altro fotografo contemporaneo che comprime molto la gamma tonale è Michael Ackerman: la sua fotografia documenta le situazioni di persone che vivono ai margini della società il cui dramma viene raccontato dall’autore attraverso immagini “imperfette”, molto sgranate e con un elevatissimo contrasto.


A.C.
Uno dei princìpi che la composizione grafica suggerisce è quello di non collocare mai la linea dell’orizzonte al centro della dimensione verticale per evitare la simmetria tra cielo e terra nel paesaggio: nel tuo lavoro “ORIZZONTI” tu la collochi volutamente ed esattamente al centro. Ne parliamo? C’è qualche riferimento alla fotografia di Luigi Ghirri?
I.L.
Il lavoro Orizzonti è il risultato di un percorso di “depurazione” e di semplificazione delle immagini ed ha una genesi precisa.
Una decina di anni fa stavo conducendo una ricerca sulla “lentezza dello sguardo” e sulla percezione del paesaggio al variare della luce naturale. Soggiornavo a Chioggia e nel raggiungere Venezia tramite il battello di linea, molto lento nel suo navigare sulle acque lagunari, la mia attenzione è stata catturata da un gruppo di palafitte poste dinnanzi all’isola di Pellestrina: le ho scelte come soggetto per la mia ricerca fotografandole più volte in diverse ore del giorno. Mi sono accorto che, per esigenze di inquadratura dei manufatti, le immagini restituite dai miei scatti riportavano un preciso posizionamento centrale rispetto alla linea di divisione tra cielo e mare. Ho approfondito la ricerca e mi sono imbattuto nel lavoro “Seascapes” del fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto: fotografando i mari nelle varie parti del mondo anche lui aveva collocato la linea dell’orizzonte al centro, mettendo sullo stesso piano i due elementi primordiali necessari alla vita, acqua e aria. Mi aveva colpito in particolar modo una sua frase: “Ogni volta che vedo il mare provo un calmante senso di sicurezza, come se visitassi la mia casa ancestrale mi imbarco in un viaggio dello sguardo”. Da quel momento ho iniziato un processo di riduzione del mio linguaggio togliendo dalle immagini tutti gli elementi non necessari che spezzavano la linea dell’orizzonte e corrompevano il suo significato di rimando all’infinito.
Ho fatto numerosi scatti per la raccolta “Orizzonti” lungo le coste italiane e anche in altri Paesi del Mediterraneo. Non fanno parte di questa raccolta le prime foto scattate sul battello tra Chioggia e Venezia che però sono state pubblicate nel 2013 sul magazine “IL FOTOGRAFO”.
In questo lavoro non c’è un consapevole riferimento alle opere di Luigi Ghirri cui accennavi nella domanda; trovo piuttosto che quello che mi può accomunare, così com’è stato riportato in un convegno del 1996 sulla fotografia di paesaggio dalla moglie Paola Bergonzoni, è lo stesso suo gesto di mettersi di fronte alle cose e di restituire attraverso le fotografie la misurazione dello spazio che si ha davanti.




A.C.
Confesso di sapere poco o nulla di tecnica fotografica, pur apprezzandone l’arte: come si ottengono quegli effetti di sovrapposizione di immagini che caratterizzano la raccolta “La città e i segni”? È un lavoro di post produzione?
I.C.
Frequento Genova almeno una volta alla settimana per le lezioni all’università. Con il lavoro “La città e i segni” ho voluto rendere omaggio ai suoi luoghi facendo emergere alcuni tratti della sua anima; quel volto cui tu prima accennavi e che vedevi emergere intermittente in una delle foto, in una sorta di gioco dinamico di interscambiabilità tra sfondo e primo piano, è il ritratto di Fabrizio De Andrè.
Le immagini che sono presenti nel mio portfolio web sono solo una parte di un progetto più complesso esposto a Casale Monferrato e che comprendeva, oltre alle fotografie a colori ottenute con la doppia esposizione, anche quattro panoramiche in bianco e nero nonché la riproduzione, sulle pareti, di parti dei testi di De Andrè. All’inaugurazione della mostra un musicista ha suonato le sue canzoni: si è trattato di un progetto veramente multisensoriale.
Tornando al “tecnico”: io realizzo la doppia esposizione “in macchina” utilizzando gli strumenti che mi mette a disposizione la fotocamera. In questo caso non entra in gioco la post produzione, non perché non ritenga apprezzabile il risultato, ma per una scelta personale: ritengo che le esposizioni multiple ottenute in macchina abbiano un valore aggiunto perché mi obbligano a mettermi in una consapevole relazione con lo spazio davanti a me per ottenere un dittico, due immagini reali che sovrapposte restituiscono, invece, una dimensione onirica.


A.C.
Le raccolte “40×40” e “Mediterraneità” sono caratterizzate dall’utilizzo di un formato rettangolare allungato che, a dispetto del risultato, non rappresentano dei veri e propri panorami e che risolvi accostando due o più foto in sequenza. Lo trovo, se vuoi, anche un po’ depistante rispetto al titolo della prima raccolta, dove ci si aspetterebbe un formato quadrato. Come nascono questi lavori?
I.C.
Ho scelto il titolo “40×40” perché è un lavoro che ho realizzato in 40 ore durante un soggiorno a Bilbao nel 2011, in occasione del mio quarantesimo compleanno. Da sempre esploro l’idea di “panorama” e in quel momento mi sono chiesto: perché non restituire l’immagine di un “panorama emozionale”, prima ancora che reale, lavorando sull’accostamento di due immagini distinte, anche in contrasto tra loro?
Questo lavoro mi ha consentito di proporre una narrazione che assomiglia, solo dal punto di vista del formato ovviamente, a quella dell’immagine panoramica.
È una modalità che ho portato avanti anche con la raccolta “Mediterraneità” in cui ho enfatizzato l’idea originaria estendendo maggiormente la dimensione orizzontale della fotografia.


A.C.
Mi hanno colpito molto gli scatti che hai fatto ai visi riprodotti su quadri antichi: i dettagli di questi volti che hai isolato e raccolto nel lavoro “SILENZI” intensificano moltissimo e, a mio avviso, in modo sorprendente la percezione da parte dello spettatore dei sentimenti attribuibili ai personaggi stessi. Era questo il tuo obiettivo?
I.C.
Questo lavoro è stato importante perché ha dato avvio alla mia ricerca sul ritratto fotografico. E poi non nego la grande soddisfazione che ho provato nell’essere stato, con questa raccolta, finalista nel 2010 al Sony World Photography Award nella categoria Professional Portraiture.
Succede che alcuni lavori partano da differenti presupposti e poi si trasformino durante il percorso: in questo caso si trattava di una collaborazione con il Museo Civico di Casale Monferrato con il quale ho collaborato nell’ambito di un progetto didattico. In quell’occasione avevo coinvolto i miei studenti in una serie di esercizi di educazione alla visione.
Ho percorso le sale del museo decine e decine di volte finché mi sono trovato in uno di quei rari momenti in cui i suoi spazi erano privi di visitatori:
in quell’istante, anziché percepire quello che avrebbe dovuto essere un normale senso di vuoto, mi sono accorto che in realtà mi trovavo in un luogo silenzioso in cui le opere esposte erano le indiscusse protagoniste.
Conoscevo di loro ogni aspetto, persino le pennellate con cui erano state realizzate dall’artista. Erano diventate per me così “confidenziali” che mi sono sentito in dovere, a conclusione del mio progetto, di proseguire oltre la semplice restituzione fotografica dei quadri e di ritornarvi per catturare i dettagli di quegli sguardi dipinti perché gli occhi di quei personaggi, diventati ormai familiari, mi avevano accompagnato per intere settimane.
Da quando ho realizzato questo lavoro la rappresentazione dei volti non mi ha mai abbandonato. Fotografo volti, o dettagli di volti, che vedo sui libri o in alcune pubblicità che noto per strada, utilizzando un linguaggio creativo contemporaneo orientato ad una ibridazione delle modalità espressive che appartengono a discipline diverse.
Penso a tal proposito al lavoro di Maurizio Galimberti e ai suoi mosaici fotografici realizzati con una Polaroid.



A.C.
Ilenio, se io dico Photoshop tu rispondi:..?
I.C.
Rispondo che la post-produzione è una componente irrinunciabile della fotografia attuale. Anche quando il risultato finale non la fa percepire, noi sappiamo che è necessaria anche semplicemente per bilanciare un’ombra o per scurire una luce che, al momento dello scatto, aveva colpito un oggetto rendendolo troppo evidente.
Ma… Quando i miei studenti mi chiedono di insegnare loro Photoshop -e ovviamente questo vale per qualsiasi programma di fotoritocco- io spiego che il software è solo un insieme di comandi che ti permettono di “fare delle cose”. Quel che davvero conta è invece la capacità di vedere a priori, nella propria mente, l’immagine finale che si vuole ottenere.
Ritengo che sia molto più importante, oggi, focalizzarsi sulla diffusione di una “cultura collettiva dell’immagine” piuttosto che sulla sola conoscenza degli strumenti.
Ritengo che sia molto più importante, oggi, focalizzarsi sulla diffusione di una “cultura collettiva dell’immagine” piuttosto che sulla sola conoscenza degli strumenti.
È per questo motivo che prima di ogni esercitazione proietto ai miei studenti tantissime fotografie: mi piacerebbe che ogni volta restassero impressi nella testa un modo di pensare e sulla retina un modo di vedere.


A.C.
A conclusione della nostra chiacchierata, ti chiedo: la rappresentazione fotografica è sempre di tipo interpretativo? Mi riferisco anche alle fotografie di interni, un ambito che riguarda direttamente la nostra rivista.
I.C.
Si, non ho dubbi in merito: dietro ogni fotografia c’è la personalità dell’autore perché ci sono delle scelte che danno forza e valore al suo punto di vista, alla decisione di utilizzare una luce che colpisce il soggetto o che viene catturata in una determinata ora del giorno e tanto altro. Ogni fotografo predilige delle situazioni spaziali che caratterizzano il suo lavoro, che fanno sì che quella fotografia sia riconoscibile.
Non è lo scatto a dare inizio alla fotografia: la fotografia si visualizza nella mente prima ancora che nel gesto di chi la realizzerà. Lo scatto non è altro che il punto di separazione tra la fase estatica della visione anticipata di ciò che sarà, rispetto alla materializzazione della sua forma finale.
A.C.
Quindi, neanche nella fase pionieristica si può parlare di rappresentazione “oggettiva”?
I.C.
Nel periodo immediatamente successivo alla nascita della fotografia e fino all’invenzione della lastra a secco (1871) l’attenzione era focalizzata sulla tecnica e pochi erano i fotografi che riuscivano a dare forma ai contenuti della rappresentazione.
Anche la fotografia che doveva avere valore documentario, quella che oggi chiameremmo “di reportage”, seguiva regole accademiche.
Mi spiego con un esempio: nel 1855 Roger Fenton, fotografo inglese considerato il primo reporter di guerra nella storia della fotografia, viene mandato in Crimea dal governo britannico per documentare la guerra che era scoppiata tra l’impero russo ed alcune nazioni europee. Poiché lo scopo di questa missione era anche quello di far arrivare in patria immagini rassicuranti circa lo stato di salute dell’esercito, ecco che si riteneva lecito costruire le scene spostando, ad esempio, cadaveri che non dovevano apparire, oppure mettendo appositamente palle di cannone su un sentiero per mostrare che in quella valle c’era stato uno scontro.
Per avere una collettiva presa di coscienza circa la natura interpretativa della tecnica fotografica si dovrà attendere ancora qualche decennio quando si comprenderà, attraverso la straight photography, che la nuova tecnica doveva affermarsi con un linguaggio autonomo, non più legato a quello dell’arte tradizionale e che, come tutti i linguaggi caratterizzati da regole, non poteva essere oggettivo.
Un fotografo, ad esempio, che è andato alla ricerca dell’oggettività, è stato Eugene Smith con il lavoro “Country Doctor” della fine degli anni ’40: è un reportage sulla vita di un medico di campagna degli Stati Uniti che egli ha documentato come fosse uno storyboard cinematografico.
A.C.
Ilenio, la prossima volta che passiamo da Casale andiamo a bere un caffè insieme? Magari accompagnato da due krumiri?
I.C.
Certo, con vero piacere e perché no … con l’occasione visitiamo anche qualche mostra!
Da un cultore dell’immagine, che cosa ci si poteva aspettare se non questo?
s f o g l i a l a g a l l e r i a